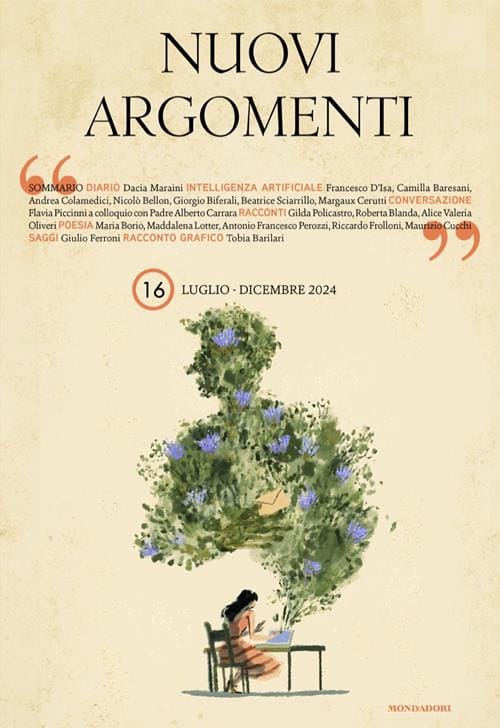Pochi giorni fa ho ricevuto una mail da un mittente a me sconosciuto. Oggetto: “L’Intelligenza Artificiale che aiuta a scolpire il Lato B”. Il testo diceva: “La personal trainer XY, specializzata in glutei perfetti, con oltre 215mila follower sui social e 5 milioni di like su TikTok, sì è affidata all’AI per ottimizzare la sua attività e rendere le sue analisi più efficienti”. Quella personal trainer è fortunata, ho pensato, perché probabilmente il suo mestiere non risentirà dell’impatto dell’intelligenza artificiale. La gente ha bisogno di motivatori che promettono di migliorare la forma fisica, i famigerati glutei scolpiti, la lotta al grasso. E difficilmente si fa bastare un fantoccio proiettato su uno schermo che spiega quali esercizi fare, c’è bisogno di un personal trainer in carne e ossa, testimonial della propria strepitosa pulsante gluteità. Ma nel mio lavoro? Nel lavoro dei miei amici scrittori e giornalisti e traduttori? È molto probabile che l’intelligenza artificiale causerà perdita di occupazione, di rilievo sociale, di senso di sé. La paura di essere sostituiti da algoritmi e processori, di aver investito tempo, energie, speranze, passione in studi che portano a lavori ormai inutili è più o meno quello che deve aver provato chi aveva una merceria dove vendeva spolette di filo e gomitoli di lana, aghi e ferri e uncinetti e il suo mondo è finito bruscamente, dissolto nella globalizzazione dei vestiti e dei maglioni prodotti chissaddove, che costano infinitamente meno di quanto possa costare farseli da soli.
Al di là della comodità di vedere un testo scritto o tradotto in una manciata di secondi, esiste un capitale umano che si vede sottrarre bruscamente la propria professionalità e si ritrova sostituito, spiazzato dal cambio di registro. Quello che costava ore di lavoro (mettiamo la traduzione di un romanzo o di un manuale) e veniva retribuito di conseguenza, ora non è più richiesto oppure vale meno. Anni di studio e di specializzazione vanificati dalle traduzioni alla carlona dell’IA. Vuoi scrivere una lettera d’amore? Nemmeno quello sforzo che serviva a ragionare e trovare le parole adeguate ti è più concesso. Dalla stucchevole poesiola in versi sciolti alla lettera in cui ti dichiari disinnamorato e lasci il partner, tutto viene compilato in pochi secondi da IA. Il modo di documentarsi cambia e diventa una questione di sinapsi di un calcolatore che nemmeno sai dove risieda, il tuo cervello è completamente spossessato dalla fatica, dalla critica, dai dubbi, dall’interpretazione.
Un mio amico scrittore non rilascia più interviste al telefono per paura di veder pubblicate, come spesso capita, risposte che non rispettano né il suo lessico né quello che voleva dire. Chiede sempre di ricevere le domande del giornalista e si scrive le risposte. Ovviamente è un lavoro non retribuito, anche faticoso, che svolge di malumore. Così, giorni fa, ha provato con l’intelligenza artificiale. Ha caricato su chat GPT il pdf del suo ultimo romanzo e le domande del giornalista, e ha chiesto che venissero formulate risposte di circa mille battute. Risultato stupefacente. Persino con l’accostamento fatto dal giornalista tra il romanzo del mio amico e Grandi speranze di Dickens, che lui non aveva letto e che invece l’IA conosceva benissimo. Quindi la risposta di AI, in un secondo aveva trovato analogie tra episodi e protagonisti dei due romanzi, con riferimenti a Satis House e Pip, che il mio amico non avrebbe mai agguantato a meno di leggere a spron battuto le 500 e passa pagine di Dickens. Gli ho scritto: “Tu sei entusiasta per questa scoperta, però che angoscia, il nostro lavoro defraudato e svilito. Ne approfitteranno per pagarlo sempre meno”, e già mi sentivo il fiato sul collo di chat GPT. Mi ha risposto: “No, invece secondo me verrà spazzata via la mediocrità, gli “splendida cornice” (e poi almeno Gpt scrive in italiano corretto senza stile poetastrico e refusi). Rimarrà chi ha qualcosa da dire”. La sua replica mi ha fatto sentire come chi negli anni Ottanta vituperava l’avvento dei computer, sostenendo che gli scrittori avrebbero perso autorialità perché i computer scrivevano i romanzi da soli. Alcune prefiche accusarono addirittura Umberto Eco sostenendo che il successo planetario di Il nome della rosa era dovuto al doping del computer. Mi sono chiesta: sto invecchiando e mi lamento come quelli che ai tempi mi sembravano dei ridicoli laudatores temporis acti?
Allora ripenso alla scrittura, a quello che da decenni perseguo per migliorarla, la nettezza delle frasi, le associazioni, il punto di vista, la creazione di uno stile personale. Per esempio, qualche tempo fa vedo su Instagram pezzi di una sfilata di Dolce&Gabbana in Sardegna, ispirata ai costumi sardi. I modelli che sfilano mi fanno pensare ai film tratti da Il pianeta delle scimmie, poi però ci sono anche abiti che fanno pensare al costume da spermatozoo gigante di Woody Allen in Il dormiglione e, nei casi più riusciti, alle creazioni di Nikolaj Rerikh per le coreografie dei Balletti russi in La sagra della primavera di Stravinskij. Se avessi voluto descrivere quella sfilata, pur senza aver mai frequentato il mondo della moda disponevo di alcune associazioni che, sommate a divagazioni di carattere sociologico mi avrebbero permesso di confezionare un pezzo ironico, con digressioni auspicabilmente interessanti, molto personale. Chat GPT, se gli avessi affibbiato il compito di scrivere per conto mio, avrebbe inserito notazioni tecniche e pertinenti, ma indubbiamente neutre. Non certo una selezione che emerge dalla smemoratezza, da ciò che ho assorbito negli anni, materiale non ancora dato in pasto all’AI perché lo rumini e lo riproponga. La capacità analogica, di fare digressioni interessanti – quindi i film visti, le storie lette, i viaggi fatti, le persone incontrate, le delusioni subite -, costruisce una personalità che è unica nell’arte del racconto, della conversazione, nel modo di porsi al prossimo e di comportarsi da cittadino, negli slanci e nelle ritrosie. Di fatto, ognuno di noi miscela pezzi di conoscenze acquisite negli anni che, all’improvviso, sbocciano nella mente formando teorie complesse. Teorie che poi solo la scrittura ci aiuta a edificare, perché il pensiero è evanescente, per esistere deve superare la prova della messa in pagina.
Torniamo però alle lettere d’amore o disamore: quella popolarità che avevo raggiunto alle medie e al liceo scrivendone per conto terzi, oggi mi verrebbe scippata dall’IA, influendo dunque sul mio senso di me. Non più reputata “una che scrive bene”, sarei venuta su diversa, mi sarei buttata su qualcos’altro, ingegnera o ricercatrice del cancro, oppure maggiordoma, un lavoro di cui ci sarà sempre richiesta, insostituibile dall’IA. Perché ormai è assodato che l’elenco delle capacità dell’IA non farà che aumentare in modo esponenziale, e dunque a molti di noi viene da chiedersi a cosa servano le persone, mica solo gli scrittori e i giornalisti ma anche architetti, insegnanti, avvocati, impiegati, matematici, geometri. In passato filosofi e teologi si sfidavano teorizzando cosa distingue l’uomo dalle bestie, ora le prove del nostro valore vanno invece definite nel confronto con un computer mangiaenergia.
In questo duello tra uomo e macchina bisogna poi distinguere tra intelligenza artificiale generativa e predittiva. Per fare un esempio: la generativa è quella che interrogo per programmare un viaggio, un menu, per scrivere un articolo sui pipistrelli nella storia della letteratura oppure un saggio sugli appetiti sessuali degli scrittori. Qui va aggiunto che in questi casi l’IA contribuisce alla disintermediazione caratteristica di questo secolo. Via le agenzie turistiche, me la cavo googlando. Via gli sportelli bancari, basta l’app sul telefono e un bancomat. Via vinili, cassette, cd, perché ascolto musica in MP3. E disintermedio anche saltando una pratica che è andata avanti per secoli, quella di andare a cercare le fonti sui libri, interrogando professori ed esperti, esercitando l’intelligenza critica. Oggi posso limitarmi a fare qualche ritocco a un testo con notizie e dati forniti sul piatto d’argento della velocità. Scelgo la disintermediazione di chat GPT, che compila il mio bel testo.
È però intelligenza artificiale generativa anche quella utilizzata per analizzare dati medici, statistici, fisici, che ha dunque un impatto molto positivo sulla cura della salute, e forse anche delle finanze e della sostenibilità. Anni fa, ho letto un libro sull’intelligenza dei cani scritto da uno psicologo comportamentale canadese, Stanley Coren. Siccome esistono svariati tipi di intelligenza, la interpersonale, la musicale, la logico-matematica, la verbale linguistica, eccetera eccetera, Coren aveva adottato, per misurare quella delle razze canine, l’addestrabilità. Cioè la capacità di imparare, che poi, nel campo canino ha come conseguenza che la vita del cane diventi più facile, riceva più premi, sia più amato, nessuno pensi di riportarlo al canile. Ma anche per noi uomini le cose non vanno diversamente. Leslie Valiant, informatico di Harvard prestigiosissimo, vincitore del premio Turing, in The importance of being educable (non l’ho letto ma su YouTube c’è un video in cui ne parla) sostiene che questa stessa caratteristica, l’addestrabilità, cioè la capacità di imparare, è la vera forma dell’intelligenza, o quantomeno che l’intelligenza non serve a granché se non sappiamo imparare. E com’è che si impara? Esiste un solo modo, l’esperienza personale diretta. Se qualcuno dei nostri cari si ammala, lo curiamo e poi muore, abbiamo fatto un concentrato di esperienza personale diretta che nessuna IA potrà sostituire. Se assistiamo a un incidente, se gioiamo per aver studiato un libro che ci ha dato una nuova visione dei problemi, se impariamo uno sport, se veniamo scippati, se facciamo del male a qualcuno e poi ne patiamo le conseguenze, se non capiamo un libro di testo e chiediamo aiuto e ancora non lo capiamo, e proviamo vergogna… Tutto questo è imparare, fare esperienza. L’esperienza non la fai come chat GPT istruendoti solo con cose utili, mirate, ma anche cazzeggiando, distraendosi dagli obiettivi, provando curiosità per tutto quello che ci circonda e cercando di soddisfarla. Questo è il succo dell’istruzione umanistica, dice Valiant. Una sorta di non specializzazione. L’IA è piatta e lineare, non reinterpreta, non ha intelligenza critica, e di ironia e autoironia nemmeno parlarne: non ha in definitiva personalità. Per Valiant quello che va promosso nelle scuole non è la comprensione ma l’educabilità. Continuare ad accendere la curiosità su qualsiasi dettaglio, cercare di imparare come funzionano le cose. Che sia uno sport, una lingua straniera, un periodo della letteratura o della storia. Affrontare un problema complesso e rielaborarlo.
Shannon Vallor è una filosofa della tecnologia dell’università di Edimburgo e ha lavorato da Google come “eticista” dell’intelligenza artificiale. In The AI Mirror: How to Reclaim Our Humanity in an Age of Machine Thinking sostiene che ci sottovalutiamo nel confronto con l’elaborazione delle macchine. “Considera l’immagine che appare sullo specchio del tuo bagno ogni mattina”, scrive. “Non è una copia del tuo corpo, o una sua imitazione. È solo un riflesso. Allo stesso modo, gli attuali sistemi di IA non producono pensieri o sentimenti più di quanto gli specchi producano corpi. Quello che producono è un nuovo tipo di riflesso”. Secondo Vallor, la capacità di essere virtuosi è specifica umana, riguarda le scelte che facciamo ogni giorno, le continue decisioni che prendiamo riguardo al nostro ruolo nel mondo. L’IA invece crea un ecosistema irresponsabile perché non può essere virtuosa, non ha coraggio, lealtà, empatia, curiosità, immaginazione. Agisce in modo lineare, senza cuore, diremmo noi. Come un panzer. E qui arriviamo all’intelligenza artificiale predittiva, progettata per fare ipotesi sul futuro ma di fatto ampiamente utilizzata dai responsabili delle risorse umane delle aziende per la selezione del personale, e anche dagli ospedali americani e britannici (forse pure dai nostri) per decidere chi dimettere perché non avrebbe speranze, o perché le sue cure costerebbero troppo per il budget dell’ospedale, liberando così il posto letto in favore di qualcuno che sia più conveniente.
Si è scoperto che la previsione del comportamento umano sul lavoro può essere influenzata dal fatto che un candidato porti gli occhiali, o che invii un curriculum in PDF anziché in Power Point. Per giunta l’IA predittiva potrebbe essere stata addestrata sulla base di contenuti discriminatori, razzisti, machisti eccetera. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la gestione dei posti letto ospedalieri. L’imponderabile non viene calcolato, l’avventura di un essere umano viene schiacciata sulla base di freddi calcoli previsionali. La guarigione prodigiosa, il successo di una cura in un caso difficile viene schiacciato sulla base di statistiche elaborate da un computer. Gli uffici risorse umane, ormai anche in Italia, danno in pasto all’IA curriculum, videointerviste, tracce lasciate sul web, permettendo che pregiudizi e magari anche notizie fake su omonimi influiscano nella valutazione di un candidato.
Infine, a margine di tutte queste considerazioni che spero vi abbiano coinvolto, sento di dover precisare che ho scritto attingendo alla mia esperienza personale, a un paio di saggi letti e rispuntati fuori dalla mia smemoratezza mentre pensavo a cosa avrei potuto dire, alla lettura di articoli del Corriere della Sera, del New York Times, del New Yorker, all’ascolto di stralci di conferenze pescate nell’archivio di YouTube, alla consultazione del dizionario Treccani on line. Insomma, la vecchia maniera. Niente chat GPT. Quello che avete finito di scorrere è, di fatto, un articolo nostalgico.